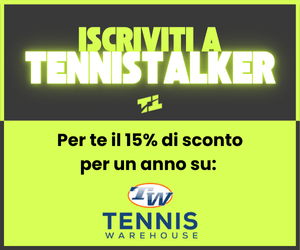Dallo scontro sulla rinuncia di Sinner in Davis agli strafalcioni di Vespa su Alcaraz, quando il tennis smette di essere solo uno sport per diventare parte del linguaggio contemporaneo. Nel bene e nel male
You Cannot Be Serious – a cura di Paolo Porrati
Nel flusso mainstream delle notizie che ci inseguono tutti i giorni attraverso l’arsenale informativo a disposizione della modernità, il tennis si è ormai conquistato una piazza d’onore. Le vittorie di Jannik Sinner, la crescita di Jasmine Paolini, le battaglie della Davis e in generale il successo del nostro movimento tennistico hanno riportato questo sport nel linguaggio quotidiano. Anche troppo.
Oggi di tennis si parla ovunque: nei telegiornali, nei talk show, sui social, nei discorsi di chi lo segue da sempre e anche in quelli di chi “ma perché nel tie-break si arriva ai sette?” È un segno di vitalità. Eppure, come ogni fenomeno che diventa popolare, il tennis paga anche il prezzo della sua stessa esposizione: tutti ne parlano, ma non tutti lo fanno a proposito. Da laboratorio di linguaggio iniziatico, il tennis è diventato un contenitore simbolico: un modo per parlare di identità, di merito, di patriottismo o di comportamento. Nulla di male, se non fosse che, nel farlo, si rischia di dimenticare il gioco, i gesti, la complessità. E di confondere la racchetta con il megafono.
Quando il tennis diventa pretesto
Negli ultimi mesi non sono mancate situazioni che testimoniano in maniera evidente e anche un po’ comica questa pericolosa deriva. Bruno Vespa, in un post divenuto virale, ha chiamato Carlos Alcaraz “Alvarez” e si è chiesto “perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner, che parla tedesco”. È un lapsus rivelatore: confonde il nome, ma soprattutto confonde il senso. Il tifo non è un dovere nazionale, e l’identità linguistica non misura l’appartenenza. Nel tennis, poi, la bandiera si rispetta tutti i giorni, quando appare di fianco al proprio nome in un qualsiasi torneo. Non è il calcio, e anche la Davis ha un significato diverso da quello, ad esempio, dei Mondiali di Calcio, prova ne sia l’approccio pragmatico (“la vinco perché è giusto farlo ma poi mi concentro sugli Slam”) adottato da tutti i campioni nel corso del tempo.
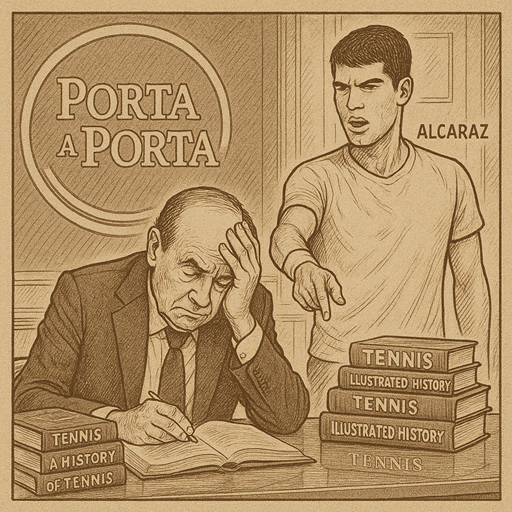
Interessante anche il post del post. Dopo la sua pubblicazione, la discussione si è spostata dal contenuto al mezzo, dal tennis a Vespa in quanto destinatario di apprezzamenti e attacchi, proprio come sarebbe accaduto se il suo sfortunato (e impreparato) Social Media Manager avesse scritto una bestialità sulla lunghezza del futuro ponte sullo stretto di Messina. Appunto, il tennis è diventato arma di linguaggio, oltre che sport di riferimento.
Cambiamo palcoscenico, e attori. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, dopo la finale di Wimbledon, ha spostato il dibattito sulla “mancata presenza delle istituzioni italiane in tribuna”. Un tema legittimo, ma fuori luogo: in uno sport non vive di eventi one-shot come le finali dei Mondiali, la rappresentanza politica si trova a scontrarsi con una ripetitività e frequenza che non riesce a gestire o a comprendere. Il carro del vincitore – Jannik in questo caso – si sposta così velocemente in giro per il mondo e appare così di frequente che salirci sopra è un lavoro difficile.
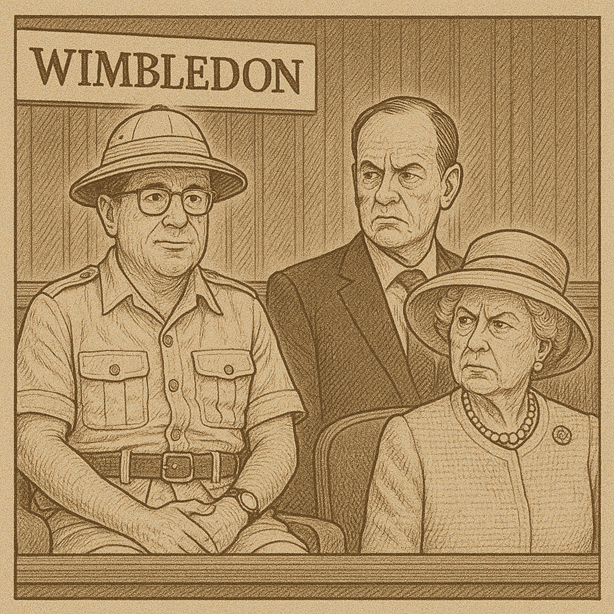
Altro esempio, sebbene con il garbo e la raffinatezza di un giornalista eccezionale, Corrado Augias ha definito Sinner “un italiano riluttante”, osservando che parla un’altra lingua e proviene da un contesto bilingue, rinunciando a tratti importanti dell’italianità come la residenza. Un giudizio che vuole sì stimolare una riflessione, ma che meriterebbe maggiore spessore in ragione della diversità culturale, fisica ed estetica che l’evoluzione dello sport propone attraverso i suoi atleti di alto livello.
La discussione sulla Coppa Davis, quando il tifo sostituisce la conoscenza
La polemica sulla mancata partecipazione di Sinner alla Coppa Davis ha rappresentato finora il punto più alto – o più basso – di questa deriva. Per giorni, giornali e talk show hanno discusso di patriottismo, di “dovere verso la maglia”, di “delusione nazionale”. Pochi hanno ricordato che la Davis non è un obbligo, ma una scelta: che nel calendario ATP ogni decisione implica priorità fisiche, logistiche e psicologiche; che un atleta non diserta, ma gestisce. In Italia, però, il dibattito ha preso subito la forma di una sentenza morale.
Nicola Pietrangeli ha parlato di “uno schiaffo allo sport italiano”. Il Codacons ha addirittura invocato la revoca delle onorificenze conferite a Sinner, come se una scelta tecnica potesse diventare un’offesa istituzionale. Nel frattempo, l’attenzione mediatica si è spostata dal tennis al patriottismo, dai campi alle bandiere, dagli allenamenti agli hashtag. È un riflesso tipicamente calcistico, applicato a uno sport che invece è l’opposto del calcio: individuale, silenzioso, pianificato. Nel tennis non esistono “convocazioni” o “ritiri”. Esiste il corpo, la mente, il tempo da gestire. Ridurre una scelta professionale a un atto di fedeltà o tradimento significa smarrire la complessità di uno sport che, per natura, vive di equilibrio.
Derive mediatiche ed epic fails
Quando il clamore cresce, gli errori diventano più visibili. Le cronache televisive, in cerca di pathos, hanno spesso trasformato la telecronaca in tifo. Lo scorso giugno, la giornalista Barbara Rossi è finita al centro di una tempesta social per un presunto “sostegno ad Alcaraz” durante la finale del Roland Garros: le è bastato un commento tecnico per essere accusata di tradimento.
Il tennis, però, non si racconta a colpi di fazione: si racconta con equilibrio e la competenza, non con la nazionalità. Poi, lo stile della Rossi, per inciso una che ha allenato campionesse come la Schiavone e la Pennetta, può anche non piacere. Si può essere nostalgici del duo Tommasi-Clerici (io non lo sono) o pasionari dell’accoppiata Bertolucci-Pero, ma questo non vuol dire che se ne debba discutere la professionalità o il modo di far vedere il tennis sottoponendoli alla gogna mediatica. Per quello, come diceva il mitico arbitro gallese di rugby Nigel Owens al giocatore che si lagnava a terra per un fallo subito “lo stadio del calcio è mezzo chilometro più avanti”.
Immancabili gli “epic fail” (warning: boomer nei dintorni) che arricchiscono e completano il quadro rendendolo transnazionale: grafiche televisive che hanno indicato Sinner vincitore quando aveva perso, post celebrativi scritti in anticipo, esibizioni spacciate per tornei dello Slam, comunicati stampa redatti da staff che ignorano le regole del circuito, e per finire il mio preferito, il commentatore ESPN a US Open 2025 che chiama Coco Gauff Simone, confondendola con la grande ginnasta Simone Biles seduta lì di fianco. Neanche gli americani sono più gli stessi di prima. Piccoli incidenti, ma sintomatici. Rivelano una fretta diffusa di parlare, commentare, occupare spazio. Il tennis è diventato contenuto: e in questo passaggio, ha perso parte del suo linguaggio.
Come parlare di tennis se si fa un altro mestiere
Non serve essere esperti per parlare di tennis con intelligenza. Non serve neanche l’intelligenza, volendo. Serve rispetto, e una certa sobrietà. Chi fa un altro mestiere – politico, conduttore, imprenditore, giornalista, generalista, leone da tastiera – può contribuire al dibattito pubblico, persino arricchendolo con la lente del proprio prisma personale e professionale. A patto che siano rispettate alcune prescrizioni fondamentali, che proviamo a riassumere in questo piccolo vademecum del tuttologo declinato nel tennis, che mi permetto di proporre a chi vorrà tenerne conto:
- Resta nel tuo campo: un politico a esempio non deve spiegare tattiche o valutare scelte atletiche. Può invece riconoscere il valore di un risultato, l’impegno, l’immagine positiva che un atleta restituisce del Paese. È sufficiente, coerente e dignitoso.
- Rispetta la competenza altrui: il linguaggio tecnico appartiene a chi conosce il tema, qui e altrove. Forzarlo è inutile: la credibilità si perde più in fretta di un break point e il ridicolo è in agguato più di sei match point sprecati. Un commento prudente è sempre più efficace di una sentenza improvvisata.
- Non usare il tennis come metafora morale: non è la rappresentazione del merito, né del carattere nazionale. È solo tennis: un equilibrio tra talento, disciplina e gestione dell’errore.
- Privilegia la sobrietà: un messaggio semplice, sincero e corretto vale più di una dichiarazione costruita. Nel tennis, la compostezza non è solo estetica: è sostanza.
- Controlla la distanza tra chi scrive per te e quello che scrive: molti post “istituzionali” o “pubblici” non sono scritti da chi li sottoscrive. Ma un errore marchiano, in questo contesto storico, diventa un potenziale disastro. La cura del linguaggio è una forma di rispetto per lo sport, oltre che di sé stessi, non un dettaglio formale.
Costruire cultura attraverso il tennis
Il tennis vive oggi un momento irripetibile: mai come ora è stato così popolare. Questo è un bene, ma anche una responsabilità. Chi racconta il tennis contribuisce a formare la percezione collettiva del suo valore. Parlarne con misura, precisione e attenzione non significa ridurne la passione: significa elevarla. Ogni parola pronunciata con competenza può aiutare a far crescere una generazione che, nel tennis, trova un modello diverso di successo, fondato sul silenzio, sulla fatica e sulla concentrazione.
C’è stato un tempo, non lontano, in cui di tennis parlavano in pochi. Quando non c’erano social, e le partite si vedevano in bianco e nero su canali stranieri, cercando un segnale traballante nella notte e scanalando fra telepromozioni ai confini dell’incredibile e spogliarelli oltre i confini del gusto. Era un linguaggio per pochi: per chi restava sveglio fino a tardi per guardare Borg o Connors su Telemontecarlo, per chi imparava le regole leggendo i trafiletti nei meandri della Gazzetta, per chi seguiva Wimbledon attraverso una cronaca scritta.
Oggi lo vediamo ovunque, in alta definizione, su tutti gli schermi.
È un progresso enorme, e bisogna esserne grati. Ma la conoscenza non cresce automaticamente con la visibilità: cresce con l’ascolto, con la curiosità, con il rispetto per chi gioca e per chi racconta. Allora, più che dire “basta parlare di tennis”, forse dovremmo dire: parliamone meglio. Con meno rumore, più precisione, e la stessa attenzione che richiede ogni colpo riuscito: silenzio, concentrazione, e la scelta giusta, un attimo prima di colpire.
P.S. Gramellini è da tempo il mio giornalista preferito, seguo la sua rubrica il Caffè da sempre e anche YCBS deve molto al suo lavoro in termini di ispirazione. Ma per favore, basta parlare di tennis! Troppo, troppo spesso e spesso troppo a sproposito. Piuttosto, e lo dico da juventino, preferisco che torni a bombardarci con le storie&leggende del suo Grande Torino, lì si capisce che competenza e passione sono così profonde e genuine da risultare piacevoli per tutti!

You cannot be serious è la nuova rubrica settimanale di Tennistalker Magazine dedicata a tutto ciò che nel tennis non rimbalza ma … fa rumore lo stesso! A cura di Paolo Porrati: accanito “quarta categoria”, è stato Giudice Arbitro per la FITP e ha partecipato da spettatore a tutti gli Slam, Finals Davis e Olimpiadi. Il suo romanzo giallo “Lo Sport del Diavolo”, pubblicato da Laurana Editore e ambientato nel mondo del tennis, è stata la sorpresa letteraria sportiva dello scorso anno.